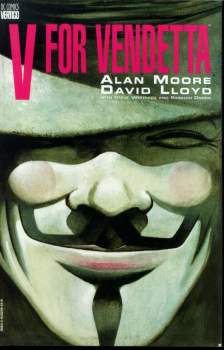Sul numero 5 della prima «Alfabeta» (era il 1979), Giuliano Gramigna pubblicò un articolo dedicato a Germano Lombardi, L’occhio di Beatrix. Ibridava nel suo i titoli di due, o forse dovrei dire tre, romanzi del di lui poco più giovane autore ligure: L’occhio di Heinrich e Cercando Beatrix (più Chi è Beatrix). A parte il fatto che gli occhi bicolori dell’ignota, inafferrabile ragazza si affacciano in vari volumi di Lombardi, compreso questo Villa con prato all’inglese che torna oggi in libreria per le edizioni il canneto dopo trentatré anni dalla sua prima edizione, Gramigna (o forse, per lui, un redattore dell’«Alfabeta» di allora) con il titolo a innesto coglieva due peculiarità dell’opera dell’amico: la tendenza agglutinante – così che di tre testi se ne fa uno – e il continuo slittamento di un personaggio nell’altro, la loro opaca definizione, la loro inconoscibilità che li rende tutti sovrapponibili. E questo malgrado la fauna umana di Lombardi esibisca una variegata casistica di deformità, malanni, inettitudini, nevrosi, perversioni: basti pensare a Lucio Batàn, l’anziano onanista cronico, nonché sadico “puro folle”, su cui si alza il sipario di Villa con prato all’inglese. Per quanto malfatti, i personaggi sono tutt’altro che dotati di personalità: il dettaglio, specie quello ripugnante, sporge fortemente, così come il nome, ma i vari tratti non si saldano mai in unità.
Lo scrittore di Oneglia, allora, si trovava già sospeso al limitare dell’oblìo che presto lo avrebbe inghiottito, più di tutti gli altri sodali del Gruppo 63, malgrado resti di lui un esemplare profilo critico a firma di Giulio Ferroni nei Contemporanei di Marzorati. Sospeso, e già come inclinato verso la dimenticanza, perché a quella data i fasti e i furori del Gruppo 63 erano lontani, e così le discussioni sul nouveau roman o sul romanzo sperimentale. Nel 1979, ossia nell’anno che preludeva all’arrivo di Altri libertini, del Nome della Rosa, nell’anno dello sperimentalismo soft e cordiale, tranquillizzante, di Se una notte d’inverno un viaggiatore, usciva Chi è Beatrix, non solo senza suscitare clamori, ma anche senza destare particolari interessi, come un frutto fuori stagione. Era il penultimo elemento della saga narrativa più destrutturata che si possa immaginare, con ogni probabilità la più destrutturata del secondo Novecento italiano.
Un corpus composto di otto “pezzi”, tra romanzi e raccolte di racconti, pubblicati nel non breve arco cronologico compreso tra il 1963 di Barcelona – il suo libro più noto, legato alla data cruciale del convegno di Palermo – e il 1979, appunto. Ospitati prima da «I Narratori» Feltrinelli, la collana dove uscivano tutte o quasi le opere più rappresentative della nuova avanguardia, transitarono poi a Rizzoli, l’editore che negli anni Settanta continuava ad ospitare anche i sempre più arditi antiromanzi di Gramigna, non solo critico finissimo ma altro romanziere ingiustamente dimenticato: L’empio Enea (1972), Il testo del racconto (1975) e Il gran trucco (1978).
Cercando Beatrix nel 1976 e Villa con prato all’inglese nel 1977 segnano il passaggio di Lombardi da Feltrinelli a Rizzoli. In queste otto opere la continuità è data dal ritorno degli stessi personaggi, a nome Giovanni Zevi, Enrico China, Berthús, Beatrix, dalla disseminazione cosmopolita delle vicende, dalla similarità delle tematiche; la discontinuità dal fatto che nessuno di loro assomiglia mai neanche a se stesso. E se la posizione e l’occasione retrospettiva permettono sempre bilanci e sguardi magnanimi, non sarà fuori luogo percepire oggi questa forma d’eccellenza, seppur non ortodossa; eccellenza che spiega l’oblìo; eccellenza nella destrutturazione.
In seguito Lombardi avrebbe pubblicato solo altri due romanzi: China il vecchio, quasi dieci anni dopo, nel 1987, e Instabile Oceano, apparso postumo nel 1993. Frattanto l’autore era mancato a Parigi, sessantasettenne, nel ’92.
Si è spesa, non con leggerezza, la parola «saga», più frequentemente adibita a sottogeneri letterari di consumo quali la fantascienza o il romanzo post-storico/neo-storico. Proprio «narratore come di una saga», ebbe a scriverne Marcello Carlino nel 2002, in occasione del conferimento del Premio Marino Piazzola alla memoria, «e però inusitata e inquietante, le cui sequenze non si svolgono secondo un ordinato filo temporale né disegnano l’unitario ritratto composito di più generazioni in successione (è la saga piuttosto di un tempo irrisolto, di una storia che non matura e invece si scompensa e si inturgida, e si frammenta o avvizzisce nel contagio tra i trascorsi e il presente dell’esperienza)».
Rileggendo oggi Lombardi, specie in questo divertente Villa con prato all’inglese, che fu ignorato anche dai critici di solito attenti al suo lavoro, come Lucio Vetri, che in Letteratura e caos non lo menziona neanche in bibliografia, in questo libro che non è il suo migliore (lo è invece probabilmente Il confine, insieme ad alcuni racconti di guerra de L’occhio di Heinrich) ma di certo il più piacevole, viene in mente con prepotenza tutta una genealogia non-italiana, segno del respiro internazionale posseduto allora dalla nostra letteratura: viene in mente il massimo cantore della stupefazione alcolica, quel Malcolm Lowry che con Under the Volcano fu molto amato, specie dagli autori in scuderia Feltrinelli, eppure ci volle tempo perché lo si ammettesse (Balestrini pagò il suo debito con una bellissima sezione de L’Editore, solo nel 1989), e comunque senza il pathos del disfacimento tragico; viene in mente William Burroughs, visionario poeta degli stati di coscienza alterati e del cut-up selvaggio, cui «il verri» dedicò un numero speciale già nel ’68, forse la prima rivista letteraria in Italia a registrarne la grandezza; ma un Burroughs senza il lirismo del lisergico; viene in mente il Thomas Pynchon di V., uscito nel medesimo ’63 di Barcelona, un libro il cui nome si espone, a sorpresa per l’Italia, già nei dibattiti del Gruppo sul romanzo sperimentale all’altezza del 1965, e che la scoordinata, sconclusionata, impossibile ricerca di Beatrix sembra costantemente evocare, ma senza l’aspirazione enciclopedica da opera-mondo che sempre abita Pynchon; viene in mente il primo Robbe-Grillet, quello del poliziesco edipico Le gomme, ma parodiato e reso definitivamente pop, come già lo aveva messo in scena il più precoce, talentuoso, irriverente dei giovani del Gruppo 63, Adriano Spatola – sedici anni in meno di Lombardi – nel suo L’Oblò. Ma come può, la metamorfosi pop, stupirci in un uomo che nei primi anni Sessanta era intimo amico del gruppo di artisti di Piazza del Popolo: di Mario Schifano, di Tano Festa, di Franco Angeli, che viveva insieme a Giosetta Fioroni?
Scorrendo queste pagine vengono in mente, persino, l’improbabile Bond di Ian Fleming, una presenza obbligata nell’immaginario del decennio, o i duri investigatori/agenti segreti di poche parole e sempre miracolosamente intuitivi che raccontava Alistair MacLean, il più fortunato autore di war e spy stories dei Sixties. Il MacLean di Base Artica Zebra, di Where Eagles Dare, di Fear is the key, amatissimo nel mondo anglosassone anche prima che i suoi romanzi diventassero film di successo, non sembra davvero lontano, in molte scene, dalla mente di Lombardi. Mente capace, però, di estrarre dal sussiego di quegli agenti segreti anche un rovescio della medaglia comico-grottesco, di fare cioè dei loro silenzi una incapacità espressiva, delle loro intuizioni folgoranti dei plateali abbagli, della loro solitudine professionale un isolamento da disadattati, della loro prontezza di spirito una paralisi costante, del loro “niente sesso siamo inglesi” una sorta di disperata incapacità di usare il corpo, persino nelle sue funzioni essenziali.

Lombardi è uno scrittore impaziente, come fu in vita con i suoi tanti lavori, i suoi tanti domicili, da una parte e dell’altra dell’Atlantico e della Manica: un viaggiatore instancabile, uno scrittore che ama immaginare ma non ama indugiare a scrivere; perciò attinge a buffe formule burocratiche per introdurre i suoi personaggi dai nomi totalmente inverosimili («Mattia Pineale Justerini, ufficiale marconista di anni 29 e Mimosa Regno, detta Ricsciò, di anni 22»; «Nuvolo Cisterna, di anni 28, ex carabiniere»; «Olimpia de Amicis Justerini aveva anni quarantanove, da ventiquattro anni vedova di James Justerini, scozzese»; «la signorina Albana Molteni, di anni 38», e così via). Nessi formulari da organigramma d’ufficio dove sembra risuonare il memorabile incipit della Ragazza Carla di Pagliarani: «Carla Dondi fu Ambrogio di anni / diciassette primo impiego stenodattilo / all’ombra del Duomo», in quanto atto di nascita, almeno in Italia, di una letteratura scarnificata nel lavacro purgatoriale del mondo del lavoro, e della sua forma mentis.
Nelle legnose specificazioni di indirizzi e luoghi vive il rifiuto di ogni narrare finto aproblematico, cioè dell’inganno sottostante a ogni “realismo”: «L’auto era una 126 Fiat presa in affitto al garage “Flowers Rent” di San Remo sito in via Maj, numero civico 32 […] Un quarto d’ora dopo era nella città di Oneglia, via Viesseux 12, nella libreria di Onesto Cavour, nativo di Asti, di anni 68». Il genere giallo, la quête investigativa, viene così ricondotta al suo etimo di verbale di polizia. E questa tendenza è perfettamente in asse con analoghe suggestioni provenienti dall’area francese, prima e dopo i colloqui di Cerisy; penso a L’inquisitoria di Pinget, su tutti, o anche alla trilogia d’esordio di Robbe-Grillet, continuamente embricata tra giallo e perplessità scopica, tra raccolta degli indizi e loro pedissequa descrizione, non significativa. Se l’indizio dovrebbe essere per sua natura un segno significante, e spesso invece l’école du regard si arena volontariamente su segni non significanti, ecco che il sottogenere del racconto giallo diventa un perfetto diverticolo che ritorce contro la narrativa di consumo i suoi stessi stereotipi. Un percorso storicamente culminante in un capolavoro come La gelosia, dove l’occhio che raccoglie e descrive è l’occhio dell’ossessivo, sì da offrire la congiunzione apparentemente impossibile del massimo di oggettività con il massimo di soggettività.
Tutto ciò cozza in maniera proficua con l’ispirazione assolutamente romanzesca (quasi nel senso di romance) delle opere di Lombardi, dove si è sempre in presenza, almeno supposta, di complotti, attentati, spionaggi, furti, fughe, contrabbandi, tradimenti, omicidi, interrogatori, violenze. Un repertorio che, se trattato diversamente, sarebbe pronto per l’etichetta di postmoderno, e invece si ferma un passo prima, laddove il repertorio è ancora assunto con metodo critico, anzi smontato senza rimontarlo, anzi senza nemmeno più lasciare in giro le istruzioni per l’uso. Qualcosa che, con tutte le differenze del caso, e pure con qualche similarità, avrebbe fatto anni più tardi Don DeLillo nel suo libro più enigmatico, I nomi.
La tensione fondamentale di Lombardi si sviluppa tra il racconto e l’afasia, male da cui sono attanagliati tutti i suoi protagonisti, e le sue trame medesime, sempre tronche, sempre incapaci di concludersi o anche solo di esplicitarsi, sottoposte a continui cambi di scena e a recisioni impreviste, non funzionali. In Villa con prato all’inglese abbiamo un plot fumettistico che ruota intorno a una collana di diamanti rubata, a certe oscure vicende dell’epoca di Salò, e a svariati morti ammazzati, alcuni dei quali nascosti da gran tempo sotto il verde piano del giardino che dà il titolo al romanzo. Seguire da presso più che mai il modello del giallo internazionale fleminghiano, e neutralizzarlo continuamente, frustrando il desiderio di un qualche appagante approdo di senso, resta l’inganno più gustoso perpetrato da Lombardi in questo suo libro.
Libro che, per la curiosa eterogenesi di cui è capace a volte la letteratura, sembra a più riprese resuscitato, senza recar coscienza del proprio antico sé, nelle pagine recenti di Verderame di Michele Mari, anch’esse dominate dalla presenza di un giardino dagli oscuri segreti, di una villa di campagna, di scheletri sepolti di nascosto e ritrovati, di una memoria flebile e vana, un “letargo di talpe, abiezione che funghisce su sé”, per dirla montalianamente.
(una versione assai più breve è apparsa su "Alfabeta 2", n. 5, dicembre 2010)