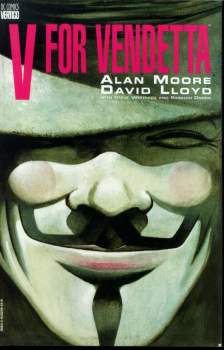Federico, mio zio, e un terzo loro amico, il dottor Abo Cardelli, furono del tutto involontariamente artefici di quello che sono oggi. Non lo seppero mai, non se n'avvidero mentre la mia metamorfosi avveniva, e forse nemmeno l'avrebbero voluta, ma la pasta molle eppur dinamica di un bambino reagisce agli stimoli potenti in modi sempre imprevedibili.
Federico era un appassionato studioso della Prima Guerra Mondiale sul fronte italiano, competente in maniera stupefacente come sanno esserlo a volte i dilettanti: conosceva a memoria ogni quota, ogni reggimento, ogni graduato, ogni evento bellico anche minimo, aveva compulsato una biblioteca immensa di reduci, memorialisti, storici, esperti militari e così via. La sua onnisciente passione, che significava anche fervido omaggio alla memoria del padre, pluridecorato di guerra, aveva contagiato mio zio e Abo Cardelli, perché loro pure appartenevano alla generazione dei figli degli uomini comandati da Cadorna, dal generale Capello e da quel cialtrone assassino del Duca d'Aosta, la cui Medaglia d'Oro al Valor Militare, eternata nel marmo di Redipuglia, grida vendetta non meno della decorazione a Bava-Beccaris, e solo come segno d'infamia dovrebbe restar lì fino alla fine dei tempi.
Quasi ogni anno questi tre amici, in varia misura nostalgici, dedicavano un viaggio alle alture isontine, o all'altopiano di Asiago, alla Carnia, alle zone sotto il Monte Nero o sotto il Pasubio, ai luoghi insomma dove si era combattuta la Grande Guerra. Un viaggio che mescolava nel mazzo carte diverse a nome turismo enogastronomico, rimpatriata amicale, osservazione storica, fantasticheria commossa, pietas verso i defunti... E una volta, avrò avuto quindici anni pressappoco, mi portarono con sé, forse perché anch'io stavo abbracciando - con la smodata voracità dell'adolescente ignaro del mondo - la stessa passione, che per me però era solo erudita, archeologica, libresca. O forse mi vollero con sé perché capivano quanto, per un bambino tim
 ido e troppo chiuso in casa, un viaggio con tre simpatici gaudenti, lupi di mare e di terra sulla sessantina, potesse essere un bel percorso di iniziazione. Ma l'incontro sconvolgente con l'ossario di Oslavia mi avrebbe cambiato per tutta la vita. E questo loro non lo sospettavano.
ido e troppo chiuso in casa, un viaggio con tre simpatici gaudenti, lupi di mare e di terra sulla sessantina, potesse essere un bel percorso di iniziazione. Ma l'incontro sconvolgente con l'ossario di Oslavia mi avrebbe cambiato per tutta la vita. E questo loro non lo sospettavano.Il pezzo che scrissi su suo padre, tanti anni dopo, non piacque a Federico, il quale si era fidato di me, mi aveva aperto la sua casa e il suo polveroso sottoscala di memorie, mi aveva mostrato foto e cimeli straordinari. Non piacque neanche a mio zio, lo so bene. Ma non potevo scriverlo in nessun altro modo.
Qualche mese fa, quasi insieme, mio zio e Federico se ne sono andati, l'uno dopo un lunghissimo calvario ospedaliero, l'altro improvvisamente, senza avvisaglie esteriori. Abo era morto poco tempo prima.
A loro tre, Alberto Bambi, Federico Marchetti, Abo Cardelli, al ricordo di quel viaggio che mi fece diventare uomo, e antimilitarista, e antifascista, a questa eredità per me così preziosa, dedico questo post.
Raccontare una storia, quando è la vera storia di un uomo, della sua famiglia, del suo lavoro e del suo tempo, di suoi amici e dei suoi ideali, non è affatto una impresa lineare, ma somiglia piuttosto alla riapertura di un vecchio baule, nel quale il cercatore di turno inaspettamente si trova di fronte mille scatole, una dentro l'altra.
Che i turisti fossero pochi e assai selezionati lo dimostra il registro: gli ospiti dell'albergo erano quasi tutti stranieri, i luoghi di provenienza sembrano una mappa della Belle-Epoque: Vienna, Parigi, Londra, Milano, San Pietroburgo... talvolta anche semplici firme raccontano delle storie. Per esempio raccontano quella di un generale russo, che ogni anno arrivava a Rimini in automobile con l'autista, la moglie, i bambini e una bambinaia. Uomo aristocratico e raffinato, lasciava i bambini al mare con l'istruttrice e ripartiva insieme alla consorte per visitare le meraviglia d'Italia, come i viaggiatori settecenteschi del Grand Tour, come Goethe e Stendhal. E ogni anno, regolarmente, spendeva più di quanto avesse a disposizione con sé, così che, tornato in patria, saldava i conti per posta. Ma nel fatale 1914 il generale dovette precipitosamente far ritorno nella Santa Madre Russia, richiamato dal deflagrare del conflitto mondiale, e sul registro una nota posteriore, aggiunta a lato della sua firma, avvisa, laconicamente, che il saldo non avverrà. Del generale non si seppe più niente, ma insieme a lui, che di lì a poco si sarebbe trovato, se pure sopravvissuto alle battaglie, di fronte al ben più imprevisto infuriare della Rivoluzione d'Ottobre, stava svanendo un mondo intero.
All'alba degli anni Venti, probabilmente nel 1921, e certo altre volte, fino al 1923, uno degli ospiti del Palace Hotel fu il grande poeta americano Ezra Pound, ormai da molto tempo europeo adottivo, in fuga anche da quell'Inghilterra dove aveva fondato il Movimento Imagista nel 1912 e il successivo Movimento Vorticista, tra i primi fenomeni dell'arte d'avanguardia del XX secolo. Pound allora si stava trasferendo a Parigi, dove avrebbe vissuto gli anni più intensi della sua esistenza, gli anni dell'amicizia
 con Joyce e con Eliot, gli anni in cui avrebbe fatto da maieuta all'Ulysses dell'irlandese e a The Waste Land dell'amico impiegato ai Lloyd's, soprattutto gli anni in cui avrebbe composto i Malatesta Cantos, di cui Luca Cesari ha dato nel 1998 una bella edizione per l'editore Scheiwiller.
con Joyce e con Eliot, gli anni in cui avrebbe fatto da maieuta all'Ulysses dell'irlandese e a The Waste Land dell'amico impiegato ai Lloyd's, soprattutto gli anni in cui avrebbe composto i Malatesta Cantos, di cui Luca Cesari ha dato nel 1998 una bella edizione per l'editore Scheiwiller.Pound amò intensamente Rimini e il suo entroterra, ne studiò approfonditamente la storia, fu incantato dalla bellezza paesistica del Montefeltro, giunse infine a identificare Sigismondo Malatesta, in un semi-delirio a metà tra poesia e politica fraintesa, con il suo ideale di condottiero, e gradualmente a identificarlo con Mussolini.
E proprio a Rimini Pound incontrò un uomo per alcuni versi simile a lui, il capitano Averardo Marchetti, gestore del Palace Hotel nonché ex ufficiale due volte decorato nella Grande Guerra. In quel medesimo torno di anni, fra l'altro, Marchetti prese parte alla Marcia su Roma, e aderì gioiosamente al nascente fascismo, così come tanti altri ex combattenti come lui, confidando che davvero quel movimento avrebbe svecchiato la nazione come prometteva, facendo giustizia sommaria del "marcio parlamentarismo". Inutile dire che le simpatie mussoliniane li unirono.
Volontario nel '15-'18, Marchetti rimase un volontario tutta la vita, malgrado le gravi ferite che aveva ricevuto in combattimento, la prima volta sul Carso, l'altra sul Piave: seguì Mussolini a Roma, si offrì per la campagna d'Etiopia, e ancora, quasi cinquantenne, partì per la Grecia, dove trovò la morte nel 1940 per congelamento. In questo instancabile, indistruttibile vitalismo, dalla inevitabile conclusione tragica, Marchetti era forse il ritratto di un'epoca intera, quella alla quale dapprima Marinetti con con i suoi proclami futuristi e poi soprattutto Mussolini riuscirono a mettersi a capo.
E la figura del capitano Marchetti, che così calorosamente si era messo al servizio di Pound nelle sue peregrinazioni per biblioteche in cerca di documenti antichi, tanto da far aprire la Gambalunghiana di Rimini apposta per lui nelle domeniche d'estate, trapassò in molti scritti del poeta americano, anche a distanza di lunghi anni. Fu una sua frase, in special modo, a rimanergli scolpita in mente, entrando a far parte dei Cantos, il capolavoro di una vita, nel Canto XLI: "Noi ci facciamo scannar per Mussolini" (il che, poi, avvenne a un'intera nazione).
Pound rimase molto ammirato dalla tempra di quest'uomo tutto d'un pezzo, così energico e ardente nelle sue manifestazioni. Ancora molti anni dopo, nel libro Jefferson e Mussolini, scrisse una formula emblematica: "A parte l'uomo di Rimini, non mi pare di aver conosciuto fascisti".
Emblematica della tragica illusione che lo accompagnò tutta la vita, e che motivò, tra l'altro, la sua nefanda adesione alla Repubblica di Salò (pagata, dopo la guerra, con tredici anni di manicomio criminale), e cioè che la nobiltà d'animo, la generosità e il sincero desiderio di costruire un mondo migliore, fossero sinonimo di fascismo.