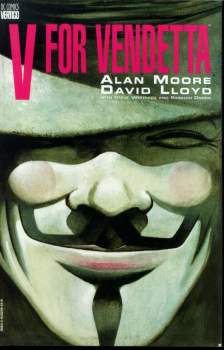Bologna, 27 gennaio 2005
L’ufficio sembra abbastanza piccolo, spartano, con una scrivania in legno curiosamente disposta in obliquo, morigeratamente ingombra di carte, documenti e pratiche, penne e agende, un calendarietto ritto con fare da palizzata contro i seccatori. Nell’angolo, tra il termosifone, la parete e la sedia, si vede un tavolino con sopra due telefoni fianco a fianco. Uno banale e grigio, l’altro rosso, ma d’un rosso niente affatto pop, anzi a modo suo ha un aspetto tetro, come quelli che negli anni Sessanta ci immaginavamo essere nella Sala Ovale e al Cremlino, quelli la cui cornetta non s’alza mai, e se si alza è solo per trasmettere nefasti impulsi di morte. Non è molto illuminato, qui dentro, anche perché fuori la luce è color lapide. Per giunta, la tendina bianca, fittamente traforata ma dozzinale, ne ferma con triste educazione da domestica in divisa più di metà. Dell’esterno si vede poco, si scorge del verde slavato, e qualche costruzione, sembrano torri.
Vorrei dirvi che sono entrato adesso in questo ufficio, che sto descrivendovi ciò che ho davanti agli occhi, o tutt’al più che l’ho fatto un tempo, e la bava nera che ne cola ora sul foglio del computer è quanto ricordo. Vorrei dirvi che il mio nome è Alan Jacobs, che sono un fotografo, che mi trovo in questo posto spaventoso oltre ogni possibile immaginazione per l’ennesima volta, e che ho un appuntamento con l’uomo che lavora qui dentro. Ma non ne ho voglia, non ha senso finger niente, oggi come una volta, dinanzi a tutto questo.
Alan Jacobs è stato qui, lui sì. Lui ha scattato la foto che vedo, tra il 1979 e il 1981. Lui di sicuro ha parlato con il direttore, l’uomo la cui presenza dietro la scrivania si intuisce forte dai segni del suo lavoro giornaliero, lui certamente ha sentito la sua voce. Kazimierz Smolen.
Io non possiedo immaginazione sufficiente per dare la parola a questi due, anzi mi sembra vergognoso esercitare la fantasia qua dentro, sforzarmi di cercare la parola ad effetto, la battuta sorprendente o commovente, la sintesi che colpisce al cuore, o anche solo il tono giusto, la credibilità nel dialogo, il timbro realistico.
Che ne so di come parla un uomo che sceglie di fare questo? Che ne so di un uomo come Smolen?
E che ne so di cosa Alan Jacobs potrebbe avergli domandato? Non so nemmeno perché lui continuava a tornare, se era per i suoi genitori, o per altri suoi parenti, o per se stesso, magari era stato qui da bambino, oppure era solo un uomo sconvolto da quanto vi aveva visto, un turista dolente fra tanti, gli occhi piccoli e strizzati come quando c’è troppa luce, perché qui ogni cosa che vedi ferisce, o forse era solo un fotografo con la passione per la storia, uno deciso a testimoniare con impressioni di pellicola quanto non si può credere, quanto ci si rifiuta di credere, e qualcuno poi cerca sempre di approfittarsene, dell’incredulità.
Non mi interessa inventare un dialoghetto morale, di questo sono sicuro.
Ma la storia c’è, e va scritta. Perdonate se violento così le scenografie del bon ton narrativo, se butto all’aria le macchine di scena, se tradisco i costumi antichi finiti di cucire ieri, le spade di legno, le corone di similoro, non è svogliatezza la mia, né mancanza di rispetto per il lettore. E’, piuttosto, il mio modo, forse maldestro, di essere listato a lutto. Inutile fare sceneggiate, stavolta.
Alan Jacobs è qui, ad Auschwitz-Birkenau, per fare delle foto. Molti anni dopo, nel 1996, le avrebbe riversate su Internet, quand’ancora i siti di privati non erano legione, una piccola homepage con poche immagini e qualche didascalia, una grafica elementare più che minimale, degli improbabili font arancio su sfondo nero, tutta roba necessaria a farsi travasare anche dai modem di allora, anfananti piccole tartarughette rosa, lente e antidiluviane trituratici di bytes. E qui, molti anni dopo ancora, nel 2003, tuttavia galleggianti nell’oceano senza tempo della rete, dove a segnare il trascorrere rapidissimo della nostra storia digitale resta solo il colpo d’occhio, l’arricciarsi di naso dinanzi all’estetica arcaizzante, o l’infuriarsi impotente alla prova dei link scaduti, vicoli divenuti ciechi, io le avrei scovate.
Tra gli scatti di Alan Jacobs, due furono quelli che presero possesso di me, gli ultimi due della lista.
Avevo riletto da poco Primo Levi, e forse la ricerca su Internet di un pellegrinaggio virtuale dentro i gironi di Auschwitz nacque proprio per quella ragione, non saprei dirlo con certezza. So però che la foto denominata “Quarantine”, di suo, non aveva gran che per attrarre l’attenzione mia, o di chiunque.

E’ una foto molto buia, scattata da dentro una baracca. L’unica pozza di luce è la porta semiaperta, che dà sull’esterno, con alberi spogli in lontananza, e uno dei famosi pilastri di cemento che sorreggevano il filo spinato elettrico. Ma il pilastro non è inquadrato come un’icona, è solo una stenta rovina in mezzo all’erba alta. Se non sapessi che è Auschwitz, potrei scambiarlo per un lampione malconcio e rugginoso. Dello spazio interno non si legge pressoché nulla, se non un primo blocco di letti a castello in legno sulla sinistra. I raggi del sole non si avventurano quasi nell’edificio, l’oscurità è densa, bituminosa. Anche i letti a castello sono orribilmente noti, eppure esistono innumerevoli immagini più significative o anche solo più nitide di questa, tanto nei film quanto nei reportages fotografici. La didascalia, inizialmente asciutta e descrittiva come le precedenti, informa il visitatore che si trova nel “Quarantine Block: Birkenau, second section, camp A”.
Ma poi, Alan Jacobs guarda la sua foto, una povera cosa, priva sia di seduzioni compositive sia di quozienti informativi, e aggiunge la frase che mi fa capire perché, con a disposizione poco spazio virtuale e connessioni precarissime e flussi informatici che al massimo si scambiavano manciate di bytes, nel 1996 ha deciso di non cestinarla, anzi di inserirla in rete.
La didascalia dice
A survivor looked at this photo and gasped in surprise: «Grass? There was never any... there. We would have eaten it».
La foto, in effetti, contiene quasi un solo colore, il verde dell’erba. Circondato da un mare di buio, c’è al centro della foto quest’occhio rettangolare che guarda verso il fuori, e il cielo è bianco, gelido, ma almeno l’erba ha una tinta brillante, che fa supporre una pioggia recente, o un velo di rugiada. Niente di poetico, s’intende, è un paesaggio intirizzito, ma in effetti una qualche forma di vita quel verde la testimonia. Lo stupore del sopravvissuto richiama in me un’analoga sorpresa: ho appena lasciato le pagine di Se questo è un uomo, e lì la fame il freddo il fango sono un tutt’uno ossessionante, perfino più di altri aspetti che a rigor di logica dovrebbero subito muovere alle lacrime. Gli uomini e le donne lasciati nudi nella neve, costretti a lavorare all’aperto con quindici-venti gradi sotto zero impantofolati in quelle infami e vezzose calzature di legno che scorticavano ferivano incidevano e infettavano la loro pelle a ogni passo, e la loro fame inestinguibile, belluina…
Erba? Non ce n’era, là…Se ci fosse stata, l’avremmo mangiata.
Ecco perché quella foto. Non è la baracca buia con i letti a castello, né il relitto di filo spinato, né gli alberi smunti come deportati, né quel cielo freddo come l’assenza di dio. E’ l’erba. Non ce n’era, allora. Mai. Ed è vero, il sopravvissuto non sta mentendo, non è la sua mente annebbiata dai patimenti a tradirlo. Anche Primo Levi lo dice, non so più dove o come, ma sarei pronto a giurarlo. Ad Auschwitz non ce n’era, di erba, solo fango o ghiaccio. Ma come si fa a fermare l’erba? Come si fa ad impedire all’erba di crescere? Quale mostruoso potere può rendere un angolo di mondo così totalmente infecondo?
Quando Lucifero fu cacciato dal Paradiso, dice Dante, e precipitato verso il basso dell’Universo, la Terra stessa inorridita si ritrasse da lui, e per non toccarlo s’aprì una voragine immane, un pozzo al cui fondo il principe degli angeli traditore si infisse, mentre all’opposto del pianeta la massa in esubero s’alzava a formare la montagna del Purgatorio. Ma i miti cosmologici medievali, per quanto grandiosi, sono per l’appunto fiabe suggestive. Ad Auschwitz, per cinque anni, è successo qualcosa che io non so spiegare, nessuno può farlo. Però dobbiamo ricordarcelo, di un posto dove gli uomini erano talmente disperati e annichiliti che avrebbero mangiato l’erba. Se ce ne fosse stata.
La seconda foto, intitolata nudamente “Office”, è quella da cui sono partito. Anche qui, la didascalia spalanca gli occhi della mente, quando non c’è immagine né angolo visuale di fossa comune o di forno crematorio dal soffitto annerito o di rotaie convergenti verso il cancello d’entrata o di recinzioni o di torrette di guardia o di Block tetro nei suoi mattoni a vista o di muro delle esecuzioni che tutti non abbiamo visto mille volte, e a cui in qualche maniera siamo ormai – fremo a dirlo, però devo – avvezzi.
La didascalia spiega che quello un tempo era l’ufficio di Rudolf Höss, il comandante del campo, l’immondo piccolo burocrate dello sterminio che ha consegnato con scrupoloso rispetto delle scadenze e untuosa ubbidienza, prima di andare a scalciare sulla stessa forca riservata a tante sue vittime, più di un milione di uomini alla morte. Ma ora, ora mentre Alan Jacobs lo inquadra e lo fissa aprendo il diaframma, non siamo nel ’44. Siamo nel 1980, probabilmente. Non c’era Rudolf Höss al lavoro lì, tra quelle carte, a usare quei telefoni, c’era un altro uomo. Kazimierz Smolen.
Quando vidi per la prima volta la foto non sapevo niente di lui, se non quanto mi diceva Jacobs stesso sul suo sito. Oggi però, che è la giornata della memoria e ho deciso che questa storia volevo raccontarla, non potevo più tenermela dentro, mi sono un po’ informato. Ho scovato, sempre su internet, un suo ritratto, e anche un’altra immagine scattatagli mentre tiene una conferenza. Ho imparato alcune cose che lo riguardano. Ma non ho intenzioni agiografiche, né biografiche. Fu un uomo molto coraggioso, però non è questo che mi importa, adesso. Se siete curiosi, il poco che ho reperito io lo trovate anche voi.
Nella didascalia, Alan Jacobs scrive:
Once Commandant Rudolf Höss’s office. At the time this photograph was taken, this room was occupied by Auschwitz Museum director Kazimierz Smolen, for five years a prisoner in the camp. The view is of the gas chamber and Krematorium I.
Kazimierz Smolen era il direttore del Museo di Auschwitz. Ed era un sopravvissuto al campo. Fin dall’inizio di quell’orrore, fin dal 1940, lui era lì. Quattro anni e mezzo ci resistette. Quattro inverni terrificanti, quelli di cui Primo Levi dice “sapevamo che da ottobre ad aprile sette su dieci di noi sarebbero morti”.
E ora era lì di nuovo. Dalla sua finestra, guardava verso le camere a gas e verso il crematorio numero uno. Fuori, tutto intorno in ogni direzione nel verde malato di quella landa atroce, che in mezzo secolo ha fatto in tempo a ricoprirsi solo di una vegetazione convulsa e contorta, si estende il più grande cimitero ebraico del mondo. Probabilmente il più grande cimitero di umani del mondo. Ma non c’è nemmeno una tomba.
Che cosa abita dentro la mente di un uomo che ha attraversato una storia così?
La prima cosa che ho pensato, con un brivido, è che da Auschwitz non si fugge. Nessuno ne è fuggito. Lo diceva anche Levi, fino a quando il peso e il terrore di risvegliarsi una mattina al grido “Wstawać!” non furono troppo, per lui.
Poi ho pensato a un qualche delirio di onnipotenza. Così come molti dei salvati svilupparono un profondissimo senso di colpa rispetto ai sommersi, per il solo fatto d’essere scampati laddove tutti o quasi erano morti, non è in fondo impossibile una fantasia inversa. Non solo io mi sono salvato, resistendo più a lungo di tutti gli altri, ma ora sono io al comando. Ora siedo io nell’ufficio di Höss, ed è ai miei ordini tutto l’innumerevole popolo di spettri che abita questo luogo, e che io vedo, li vedo tutti, li vedo in ogni luogo, strati su strati trasparenti e fiochi quasi com’erano in vita, con le loro carni sbiancate dal tifo e dalla fame e chiazzate dal sudiciume, tenui ma tutti presenti, perché io c’ero, io non sono come i turisti che contemplano poche rovine e s’immaginano il resto poveramente con l’immaginazione di gente che non è mai stata a lavorare a piedi nudi nella neve, che non mangiava rape e sporcizia a bagno in una zuppa latrinosa, che non dormiva tra morenti o dissenterici, che non veniva costretta a cagare a centinaia in fila dentro baracche di cui nessuno può supporre il tanfo, gente che non ha mai trasportato i rulli per spianare le strade, che non ha mai visto le cose che ho visto io, gente che non sa e non può sapere cos’era Auschwitz, e il peggio che si figurano non è nemmeno la pallida ombra della verità. Ora comando io questa nave dei morti, e mentre il ferro arrugginisce, il legno si consuma, le macerie piano piano si sfanno, di lavoro non ce n’è più, da fare. Non si uccidono più i morti, solo la retorica può sostenerlo, il nostro sacrificio è già stato consumato. Manco solo io, o quasi. E guardo fuori, la camera a gas e il crematorio. E rispondo alle domande cortesi di questo signore, questo fotografo americano, o inglese, o chi se ne importa di dove.