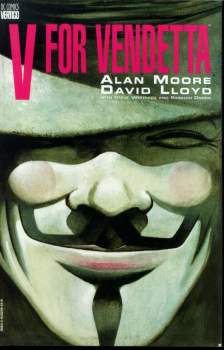Recuperare un materiale accatastato dal suo luogo di accumulo e trasferirlo, con breve viaggio, in un altrove nel quale ripristinare, potenziata, la sua funzione: contenere. Questo pensiero ha alimentato la fantastica installazione di Marco Croatti e Massimiliano Canarecci IN A BOX per le danzatrici di Movimento Centrale guidate da Claudio Gasparotto. Il materiale è il cartone, la sua ur-forma o iper-forma è proprio la scatola.
Recuperare un materiale accatastato dal suo luogo di accumulo e trasferirlo, con breve viaggio, in un altrove nel quale ripristinare, potenziata, la sua funzione: contenere. Questo pensiero ha alimentato la fantastica installazione di Marco Croatti e Massimiliano Canarecci IN A BOX per le danzatrici di Movimento Centrale guidate da Claudio Gasparotto. Il materiale è il cartone, la sua ur-forma o iper-forma è proprio la scatola.IN A BOX, smontato e rimontato, reinventato ogni volta, ha avuto diverse realizzazioni, in luoghi e per occasioni assai diverse. Questa che riporto è la nota che scrissi per accompagnare il programma di sala al tempo del suo primissimo prender forma.
Ringrazio Marco e Massimiliano che ancora una volta mi vollero con loro, mi attrassero dentro la loro scatola di meraviglie.
Forse un paio di millenni prima di Gutenberg, e certo molti secoli prima della battaglia di Samarcanda (751 d.C.), che avrebbe regalato all’Occidente barbaro e arretrato l’insperato dono di un prezioso oro bianco con cui pensionare la pergamena, in Cina già esistevano i caratteri mobili della stampa, e la carta.
La carta, e l’arte dei segni, sono stati a lungo un possesso esclusivo del Regno del Centro, nel suo solenne e sdegnoso isolamento. Ancora nel XX secolo un fine intellettuale come Roland Barthes poteva parlare di «Impero dei Segni» per quell'altra isola inaccessibile, quel Giappone arcaico e futuribile che i suoi occhi di semiologo europeo vedevano con tutta la distanza e la meraviglia di una inconciliabile, radicale alterità
Ma i segni non sono solo scrittura, e la carta non è solo un supporto di parole.
Segni sono le movenze della danza, la pittura gestuale ed effimera che un corpo traccia nell’aria, segni sono le ferite che il tempo, e l’ambiente, infliggono alla roccia scavata dall’acqua, all’albero squassato dal fulmine, all’uomo reso dolente dalla malattia. E la carta è un contenitore di segni e parole tanto quanto lo è di oggetti, di materia, negli scatoloni che contengono questo spazio scenico, nei cartoni da trasporto che sono piccoli mondi passibili di infinite concentrazioni, ammassi, impilamenti, o successivi inscatolamenti, così che non v’è forse mai un esterno che sia del tutto esterno, e non v’è esterno che a sua volta non circoscriva altro, non si spalanchi su altro. Segni sono le cuciture che fanno su di una veste un ricamo, o su un corpo ferito, chirurgizzato, lasciano traccia di un rapporto tra dent
Segni sono le cuciture che fanno su di una veste un ricamo, o su un corpo ferito, chirurgizzato, lasciano traccia di un rapporto tra dent ro e fuori; e non v’è poi bisogno di un bisturi per entrare nel corpo altrui, se continuamente i medicinali, come pillole o gocce, raggi o creme, iniezioni o manipolazioni, rimodellano soma e psiche, alla ricerca affannosa di salute o salvezza, di benessere o di pace dai propri demoni.
ro e fuori; e non v’è poi bisogno di un bisturi per entrare nel corpo altrui, se continuamente i medicinali, come pillole o gocce, raggi o creme, iniezioni o manipolazioni, rimodellano soma e psiche, alla ricerca affannosa di salute o salvezza, di benessere o di pace dai propri demoni.
Scatole sono le case, scatole le stanze, scatole inscatolano gli alimenti o i prodotti nei supermarket, e sempre la carta del packaging strilla con colori vivaci messaggi seduttivi, prima di finire nel cestino, immolata alla necessaria fruizione dell’oggetto. Dunque la carta che contiene e trasporta è anche la carta inutile, il rifiuto, che qui si offre nella sua povertà acromatica, nelle sue lacerazioni e consunzioni, incisa e ricucita a costruire il nuovo derma/luogo artistico nel quale si agitano dinamiche di sensi accesi, dripping di movimento, e un’energia e una pulsazione che sono ritmo vitale, circolazione di messaggi, riciclaggio di merci, ardore metabolico.
Anche i segni sono ferite sul bianco della pagina intonsa, e anche il foglio di carta è contenitore di un teatro, o di un cinema, forse, di visioni ideali.
La materia di cui siamo fatti, di cui ogni cosa è fatta, canta nel corrompersi e nel rappezzarsi, e se al silenzio tutti siamo infine condotti, è danzando sonoramente che vi si inclina.
Ma i segni non sono solo scrittura, e la carta non è solo un supporto di parole.
Segni sono le movenze della danza, la pittura gestuale ed effimera che un corpo traccia nell’aria, segni sono le ferite che il tempo, e l’ambiente, infliggono alla roccia scavata dall’acqua, all’albero squassato dal fulmine, all’uomo reso dolente dalla malattia. E la carta è un contenitore di segni e parole tanto quanto lo è di oggetti, di materia, negli scatoloni che contengono questo spazio scenico, nei cartoni da trasporto che sono piccoli mondi passibili di infinite concentrazioni, ammassi, impilamenti, o successivi inscatolamenti, così che non v’è forse mai un esterno che sia del tutto esterno, e non v’è esterno che a sua volta non circoscriva altro, non si spalanchi su altro.
 Segni sono le cuciture che fanno su di una veste un ricamo, o su un corpo ferito, chirurgizzato, lasciano traccia di un rapporto tra dent
Segni sono le cuciture che fanno su di una veste un ricamo, o su un corpo ferito, chirurgizzato, lasciano traccia di un rapporto tra dent ro e fuori; e non v’è poi bisogno di un bisturi per entrare nel corpo altrui, se continuamente i medicinali, come pillole o gocce, raggi o creme, iniezioni o manipolazioni, rimodellano soma e psiche, alla ricerca affannosa di salute o salvezza, di benessere o di pace dai propri demoni.
ro e fuori; e non v’è poi bisogno di un bisturi per entrare nel corpo altrui, se continuamente i medicinali, come pillole o gocce, raggi o creme, iniezioni o manipolazioni, rimodellano soma e psiche, alla ricerca affannosa di salute o salvezza, di benessere o di pace dai propri demoni.Scatole sono le case, scatole le stanze, scatole inscatolano gli alimenti o i prodotti nei supermarket, e sempre la carta del packaging strilla con colori vivaci messaggi seduttivi, prima di finire nel cestino, immolata alla necessaria fruizione dell’oggetto. Dunque la carta che contiene e trasporta è anche la carta inutile, il rifiuto, che qui si offre nella sua povertà acromatica, nelle sue lacerazioni e consunzioni, incisa e ricucita a costruire il nuovo derma/luogo artistico nel quale si agitano dinamiche di sensi accesi, dripping di movimento, e un’energia e una pulsazione che sono ritmo vitale, circolazione di messaggi, riciclaggio di merci, ardore metabolico.
Anche i segni sono ferite sul bianco della pagina intonsa, e anche il foglio di carta è contenitore di un teatro, o di un cinema, forse, di visioni ideali.
La materia di cui siamo fatti, di cui ogni cosa è fatta, canta nel corrompersi e nel rappezzarsi, e se al silenzio tutti siamo infine condotti, è danzando sonoramente che vi si inclina.